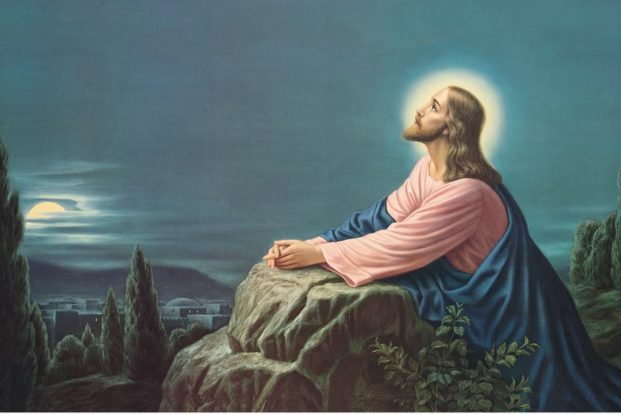Per grazia di Dio ognuno può continuare a recitare il “Padre Nostro” privatamente come da secoli si è sempre fatto con piena fedeltà a Cristo e al Vangelo, dicendo «Non ci indurre in tentazione» (Mt 6,13 e Lc 11,4).
Ma il nuovo Messale nella liturgia della Messa ci fa cambiare a livello ecclesiale questa sesta espressione della Preghiera di Gesù, in un modo che, non è corretta dal punto di vista etimologico, e a mio parere, soprattutto dal punto di vista spirituale.
Invece di «Non ci indurre in tentazione» dovremmo dire «Non abbandonarci alla tentazione». Di certo non è corretto affermare che questa nuova traduzione sia quella “giusta” mentre la traduzione classica sia quella errata. Credo infatti che la verità sia esattamente il contrario; pertanto la nuova traduzione è da considerarsi un falso dal punto di vista letterale e morale, in quanto non è “conforme al testo originale” e quindi non si può affermare che è “corrispondente, appropriata e in sintonia con il testo di Gesù”. Si tratta piuttosto di una correzione e di un travisamento della Verità delle parole del Signore.
L’EQUIVOCO DEL CAMBIAMENTO
E’ ampiamente dimostrato dagli Esegeti che il testo originale del verbo usato da Gesù è «Indurre» e che la parola «Tentazione» è da considerarsi come “Prova”.
Infatti, il Vangelo è stato scritto in lingua greca, traducendo fedelmente l’Aramaico parlato da Gesù e dai suoi discepoli. Dal termine greco “Eisenekes”, tradotto poi in Latino con “Inducas”, si arriva alla versione italiana di «Indurre», ovvero: condurre – far entrare den- tro – portare – mettere in. Quindi, la “nuova traduzione” è una classica operazione di tipo “pastoralmente corretta”, ma è estranea al Vangelo e in contrasto con l’interpretazione ese- getica, in quanto non rispecchia la traduzione letterale e fedele del testo aramaico.
1
E’ anche vero che certe espressioni del Vangelo sono di difficile comprensione e si presta- no facilmente ad errori di traduzione ed interpretazione. Ma è ancor più vero che la Chiesa non è autorizzata ad eseguire operazioni di cambiamento, riduzione e mitigazione del lin- guaggio del Signore per adattarlo alla nostra mentalità, per adeguarlo al mondo e ai tempi, soprattutto quando i termini sono corretti dal punto di vista etimologico. La Chiesa ha il compito, invece, di tradurre letteralmente e filologicamente le parole di Gesù, di interpre- tarle nel loro senso originale e in modo corretto per ciò che Egli intendeva dire, per poi spiegarle ai fedeli nel loro significato autentico, senza cambiarle, attraverso la catechesi e la predicazione, evitando qualsiasi forma di manipolazione a livello divulgativo e pastora- le. Così hanno fatto Teologi e Papi fino all’attuale catechismo della Chiesa Cattolica.
Questo cambiamento non è neppure una necessaria “traduzione di senso” perché possa es- sere capita bene da tutti, così che nessuno si scandalizzi, pensando che Dio sia un Padre che induce al peccato i suoi figli, però è altrettanto scandaloso pensare che un Padre ab- bandoni i suoi figli.
In realtà siamo davanti ad un episodio di “Vangelo tradotto” come “Vangelo tradito”, cor- retto e semplificato in modo inopportuno e sbagliato.
TENTAZIONE O PECCATO?
Da dove parte questo errore di traduzione e interpretazione?
Possiamo dire che nasce da un equivoco di pensiero che riguarda il termine «Tentazione». Rimandiamo a dopo l’interpretazione giusta della parola «Tentazione» che significa «Prova» (di Dio), dentro la cui volontà e permissione si inserisce la prova del “Tentatore” (Mt 4,30).
Per il momento lasciamo al sostantivo il suo valore semantico più comunemente usato di “tentazione”. Ora con questa parola c’è il rischio di scambiare, o meglio, di confondere la tentazione con il peccato, per cui si dice: «Dio non può indurci al peccato» e «Il Tentatore al male, all’errore, al peccato è solo il Demonio».
Questo è vero! Infatti, Giacomo (1,13) scrive : “Dio non tenta nessuno al male”.
Precisiamo prima che «peccato» etimologicamente dall’uso latino significa «errore» che si commette “a proprio danno”, a propria sconfitta. Ovviamente si tratta di un errore nei confronti della legge di Dio e di Cristo, quindi si tratta di una disobbedienza, di un’infra- zione a norme e divieti stabiliti da Dio per il nostro bene, per la verità e la giustizia.
In ultima analisi, possiamo definire il peccato come una mancanza di fede e di amore a Dio Padre e al suo Figlio Gesù.
Precisato questo, non si deve equivocare pensando che la tentazione sia il peccato.
Una persona, infatti, può sentire una fortissima tentazione da parte del demonio, o della sua carne (Giac 1,14), o del mondo, ma senza fare peccato. Una cosa è sentire la tentazio- ne, un’altra cosa è acconsentire alla tentazione, commettendo il peccato, il male, l’erro- re. Proprio per non fare peccato Gesù ci dice di “vegliare e pregare” (Mt 26,41).
Si pecca, non quando si sente la tentazione, ma quando si acconsente alla tentazione con piena avvertenza, lucida coscienza e con deliberato consenso, determinata volontà.
I Santi hanno sentito e subìto le tentazioni più forti e seducenti, più malvagie e vessatorie, ma non hanno acconsentito, non hanno ceduto al peccato, hanno resistito alle tentazioni, le hanno allontanate, non sono caduti nel male. Inoltre, proprio vincendo queste tentazioni hanno acquisito meriti e premi, grazie e ricompense qui sulla Terra e poi in cielo. I Santi sono stati provati dalle tentazioni, ma non sedotti e ingannati.
2
Sarebbe bastato far capire questa distinzione morale tra tentazione e peccato per smontare l’incomprensione e l’equivoco di interpretazione delle parole di Gesù.
Purtroppo, sia i nuovi catechismi dell’Iniziazione Cristiana che la predicazione sono ben lontani dal lavoro di spiegazione delle Preghiere (in particolare del “Padre Nostro”), come pure dei Dieci Comandamenti, dei peccati verso Dio, verso il prossimo e sé stessi, della dottrina teologica e morale, del catechismo della Chiesa Cattolica.
Da qui nascono confusione e incertezza.
UNA DIGRESSIONE SULLA QUINTA RICHIESTA
Prima di affrontare il problema del versetto in questione mi permetto di fare una digressione. Visto che oggi c’è l’usanza di cambiamenti e di adeguamenti, sarebbe stato più opportuno cambiare le parole: «rimetti / rimettiamo» e «debiti / debitore», oggi poco comprensibili e poco in linea con la nostra cultura.
Notiamo che Matteo, scrivendo perlopiù ai Cristiani provenienti dal Giudaismo e dalla cultura orientale, usa questi termini di carattere giuridico: “Remissione dei debiti” (Mt 6,12), cioè “Condono di insoluti di giustizia o di ingiustizie”.
Invece Luca, che scrive ai Cristiani provenienti dal paganesimo e dalle culture occidentali, greche e romane, usa questi termini di carattere spirituale: “Perdono dei peccati” (Lc 11,4). Quindi Luca avrebbe già operato un adattamento di Matteo.
Nella nuova traduzione, giustamente, si è aggiunta la parola «anche» che si trova nell’ori- ginale, ma poi non si è provveduto a cambiare il tempo del verbo «rimettiamo», che non è al presente bensì al passato: quindi è «Abbiamo rimesso», come a dire che noi possiamo chiedere e ottenere la remissione dei nostri debiti perché anche noi abbiamo già concesso la remissione dei debiti al nostro prossimo. Così ha senso la parola «anche».
Al suo posto Luca mette la parola «infatti» cioè «allo stesso modo», «nello stesso tempo», «così come», «perché», per dire che il perdono ai nostri debitori è già dato da noi, è proto- collato, è pagato, per il presente, il passato e il futuro. Volendo unire le redazioni di Mat- teo e di Luca, si potrebbe dire così: «Perdona a noi i nostri peccati, come anche noi li ab- biamo perdonati ai nostri debitori» (Matteo) oppure «infatti anche noi perdoniamo ogni nostro debitore» (Luca).
UNA DIGRESSIONE SULLA SETTIMA RICHIESTA
Già che siamo in tema di cambiamenti, c’è da aggiungere che nel nuovo Messale si è persa l’occasione di portare all’originale di traduzione e di senso l’espressione: «Ma liberaci dal male». Infatti la traduzione fedele del testo di Gesù è «Ma liberaci dal maligno». Sembra che oggi non si voglia più parlare del “Maligno” come di un essere personale, ne- mico, cattivo, falso, omicida, superbo, ribelle ecc.
Si preferisce, invece, parlare di “male” generico, astratto, impersonale che però non è certo nel pensiero, nelle parole, nella cultura di Gesù e del suo tempo. Oggigiorno si cerca di oscurare il maligno, Satana, il demonio, perfino di negarlo, perché non è ecclesialmente corretto, però è dottrinalmente vera la sua esistenza, la sua presenza e la sua opera, e quin- di è pastoralmente necessaria una preghiera specifica.
Sarebbe stato più urgente e necessario sostituire la parola male con il termine originale maligno, perché oggi il concetto di male sembra aver perso i suoi reali connotati.
Infatti il male è diventato un pensiero debole e liquido, al punto tale che non solo non si sa più cosa sia, ma addirittura viene considerato come un bene, come un diritto.
3
In nome di una pietà umanitaria e misericordiosa, di una filantropia generale e antidiscri- minatoria, si finisce con l’accondiscendere al male e al peccato, fino al punto di non voler- lo più giudicare, tanto meno condannare per rispetto a criteri di psicologia, di sociologia, di cultura, di situazione personale.
In effetti, la categoria di male si presta facilmente ad essere manipolata come un bene, ad essere vestita in modo tale da presentare come cose accettabili e sostenibili, addirittura co- me diritti di libertà, delle vere e proprie immoralità pagane, dei peccati gravi, delle istinti- vità basse, brutali, aberranti, tipiche di una “Babilonia” anticristica ed antiecclesiale.
Oggi questi fenomeni di negazione del peccato, di travisamento del Male in Bene sono una vera e propria emergenza morale, dottrinale e pastorale. Con i sofismi del discernimento e della comprensione nei confronti di condizionamenti psicologici, di situazioni sociali, di circostanze ambientali si può arrivare a demolire la Dottrina della fede e della morale, e così il peccato non è più peccato, anzi… Guai a parlare di peccato, di vizio, di male!
Paradossalmente succede che, per difendere, garantire e salvare il peccatore, si corregge e accantona la dottrina teologica e morale, si negano le azioni intrinsecamente cattive, si ar- riva quasi a giustificare l’immoralità, fino a negare le norme morali oggettive e assolute, legate alla legge naturale e rivelata.
Questo è il pericolo della nuova religione che non è più la religione di Dio, ma è la re- ligione dell’uomo. L’uomo si mette al posto di Dio emanando le proprie leggi che non corrispondono più alle verità di Dio e che non sono conformi a Cristo “Via Verità e Vita”, ma rispecchiano piuttosto ciò che l’uomo pensa e vuole, rincorrendo falsi idoli e istinti malati e deformi, in nome, non tanto della sua libertà, ma della sua autonomia da Dio, del- la sua indipendenza dalla Parola di Dio, dalla sua contrapposizione alla legge e alla volon- tà di Dio.
Peraltro, parlando solo di Male e non di Maligno si perde di vista anche la necessità di de- nunciare il Maligno e i Maligni, di combattere e vincere i gravi fenomeni del satanismo, del maleficio, della vessazione e possessione diabolica.
Una preghiera formulata come «Liberaci dal Maligno» andrebbe a denunciare questo gra- ve fenomeno e, inoltre, favorirebbe la fede in un Padre onnipotente e difensore, un Padre impegnato a liberare e guarire i suoi figli.
Pregando «Liberaci dal Maligno» si prenderebbe più coscienza sia della presenza e dell’o- pera del demonio e dell’anticristo, sia del nostro dovere di sottrarci alla sua schiavitù e fal- sità, di combattere per la difesa della legge di Dio e del regno di Cristo, contro quel male e quel peccato che dev’essere evitato, esorcizzato, vinto e allontanato.
Dal momento che non si è pensato di cambiare l’espressione ultima del “Padre Nostro” si sarebbe potuto almeno fare un’aggiunta alla preghiera che segue nella liturgia, in questo modo: «Liberaci, o Signore, dal Maligno e da tutti i mali…».
In conclusione, torno a ribadire il concetto che il “Padre Nostro” nella redazione del Van- gelo di Gesù è sempre da preferire alle altre traduzioni della Chiesa, perché questa è la re- gola della fede. Di questa regola, mi sembrano più rispettosi i fratelli ortodossi, e persino i Protestanti, che non hanno voluto cambiare il passo: «Non ci indurre in tentazione» nella loro preghiera.
LA VICENDA EMBLEMATICA DI PIETRO
Prima di iniziare l’esame approfondito del problema, vorrei sottolineare la vicenda di Pie- tro, emblematica in 3 punti.
4
1. In Lc 22,31-32 Gesù rivela a Pietro che Dio ha concesso a Satana il permesso di “vagliare gli apostoli come il grano”, e al tempo stesso Gesù dice di aver pregato il Pa- dre per Pietro “affinché non venisse meno la sua fede”, ossia Gesù dice che Lui stesso ha pregato il Padre perché Pietro non fosse “condotto” nella tentazione satanica, nella prova di perdere la fede, così che poi Pietro, una volta “tornato”, convertito da questa debolezza e pochezza di Fede, confermasse gli altri Apostoli suoi fratelli.
2. In Mt 16,21-23 Gesù parla della necessità di dover andare verso la passione e la morte. Allora Pietro lo rimprovera, e con l’auspicio che Dio non faccia accadere ciò, gli si pre- senta idealmente davanti per impedire che Gesù sia condotto verso questo destino di prova dolorosa. In quel momento, per Gesù, Pietro incarna il pensiero degli uomini e non il pensiero e la volontà di Dio, e addirittura Pietro diventa egli stesso tentazione e prova di Satana verso Gesù. Infatti Gesù rivolgendosi a Pietro dice: “Vai dietro di me, Satana!”. Satana agisce attraverso Pietro per far “inciampare” Gesù, per indurlo a cade- re nel peccato di autonomia e disobbedienza al Padre.
3. In Gv 21,18-19 Gesù dice a Pietro che quando era giovane era autonomo e libero, ma in- vecchiando dovrà dipendere da “un altro che lo sorregge, lo veste e lo porterà dove lui non vuole”. Perché? Appunto perché Pietro probabilmente pregava come Gesù ha inse- gnato nel “Padre Nostro”: cioè di non essere «condotto nella prova» della morte di mar- tire. Chi sia questo altro che “lo porterà dove lui non vuole” è facile da capire: o è il Pa- dre Celeste, o è lo Spirito Santo che lo sorregge e lo veste con cura e amore, per poi condurlo docilmente alla “prova” di morte del martirio, alla sequela di Cristo (Matteo 16,24-25), con la quale avrebbe glorificato Dio.
Questi tre passi riferiti a Pietro (e quindi alla Chiesa e a noi) si inquadrano perfettamente nella preghiera: «Non ci indurre in tentazione», (cioè non ci indurre alla prova), sia perché è la preghiera che faceva Gesù stesso per Pietro, sia perché può essere lo stesso cammino della volontà di Dio, sia perché è la stessa prospettiva e sequela dei discepoli di Gesù, rap- presentati da Pietro.
IL PASSO «NON CI INDURRE IN TENTAZIONE»
Vediamo ora di iniziare l’analisi del passo in questione: «Non ci indurre in tentazione». Prima di approfondire la parola «Tentazione» vediamo di capire bene l’espressione «Non ci indurre», lasciando per ora alla parola “Tentazione” il duplice significato di “Prova – Esame di Dio” e di “Provocazione – Istigazione del Maligno”.
Notiamo subito che il passo è riportato in modo perfettamente uguale sia da Matteo (6,13) che da Luca (11,4), segno che i lettori di ogni lingua e cultura non vi trovavano nulla di problematico o difficile.
Partiamo dalla constatazione che tutte le espressioni del “Padre Nostro” sono positive, cioè auspicano e chiedono a Dio Padre cose buone e giuste, rette e vere. E non potrebbe essere diversamente, sia per rispetto al Padre a cui è rivolta la preghiera, sia per rispetto al figlio suo Gesù, che ha insegnato a noi questa preghiera dopo aver Egli stesso dato esempio e detto di pregare (Lc11,1-4). Quindi necessariamente dev’essere positiva anche la domanda che riguarda una criticità (in questo caso: la Prova e la Tentazione), anche se, come tale, dev’essere preceduta da un «non».
E’ importante capire questo concetto, sia per non tradurre l’espressione in modo negativo, come succede quando viene sostituita da «Non abbandonarci», sia soprattutto per non ca- dere nei pericoli dell’eresia e dell’ateismo, a riguardo di ciò che è visto e che accade di ne- gativo, come quando per esempio si crede a un Dio cattivo e punitivo, ad un destino casuale e crudele, a un Dio assente, inerme, cieco e muto nei confronti del male.
5
Gesù non avrebbe mai pensato a un Padre che abbandona e si assenta dai figli.
Per Gesù il Padre Celeste è sempre presente e operativo anche in situazioni di male (prove e tentazioni), con Grazie di salvezza e redenzione, di purificazione e conversione, di fedel- tà e forza, di bene e di vita, di premio e ricompensa.
La preghiera di Gesù è inserita nella mentalità profondamente religiosa del suo ambiente e della sua cultura, che si fonda sulla fede in un Dio che è autore, protagonista, operatore, conduttore di ogni avvenimento; in un Dio che è pianificatore, controllore e regolatore di tutto ciò che dà e toglie ai suoi figli, con finalità santificatrici e purificatrici, nel rispetto della nostra libertà e responsabilità, coscienza e volontà.
Quindi, nulla sfugge alla sapienza e onnipotenza di Dio, in tutto ciò che succede c’è la vo- lontà di Dio; in tutto c’è l’opera e l’intervento di Dio, la guida, la legge, la direttiva di Dio, la proposta, la permissione, la santità, la gloria di Dio, la provvidenza, l’assistenza, l’amore di Dio Padre, che sa trarre il bene anche dal male, che fa concorrere al bene anche il male, che sa educare al bene e operare il bene, come pure correggere il male, dominare il male, salvare e guarire dal male, perdonare e convertire dal male.
Avendo assodato tutta questa attività e positività di Dio Padre, proviamo a mettere in positi- vo la preghiera di Gesù, togliendo il «non» al «non ci indurre». Allora dovremmo dire così: «Evitaci le tue prove dolorose, penose, faticose, spogliatrici, difficili, drammatiche» e «Risparmiaci le tentazioni pericolose, cattive, distruttive, malefiche, mortali del Maligno».
Questo risvolto positivo della Preghiera ci porta a capire un aspetto della fede spesso tra- scurato e dimenticato. Infatti, se da una parte la Fede ci fa vedere e lodare Dio per le Gra- zie da Lui ricevute, come il dono del pane e della Provvidenza (Dacci oggi il nostro pa- ne…), come il dono del Perdono e della Pace (Rimetti a noi…), dall’altra parte la Fede de- ve farci vedere anche le Grazie legate a quei mali che Dio ci evita e ci risparmia, a cui ci sottrae e ci condona con la sua Protezione, il suo Soccorso, il suo Aiuto, per la sua Miseri- cordia, il suo Perdono, la sua Remissione, la sua Grazia, la sua Bontà.
IL MALE E LA PROVA
Quali sono i mali per i quali dobbiamo chiedere l’intervento di Dio Padre affinchè li tenga da noi lontani e quindi nei quali preghiamo di non indurci?
Possiamo rispondere che sono le occasioni di peccato e vizio, le malattie dolorose e letali, gli incidenti e gli infortuni, i furti e le aggressioni, le persecuzioni e le uccisioni, le truffe e le estorsioni, le crisi sanitarie ed economiche, le ingiustizie e le prepotenze, i sacrifici pe- santi e stressanti, le distruzioni e le guerre, ogni genere di malattie spirituali, psichiche e fisiche, come pure i turbamenti, le negatività, gli influssi, le infestazioni, le possessioni de- gli spiriti impuri e demoniaci.
Questa Fede in Dio Padre che “ci dona il bene e ci risparmia il male”, ci mantiene umili e miti, sereni e tranquilli, riconoscenti e gioiosi, religiosi e praticanti, devoti e fedeli; ci rende capaci di lodare e ringraziare il Signore per le prove della vita, e disponibili ad of- frirle al Signore per le nostre e sue intenzioni. Questa Fede rimuove in noi ogni sentimento negativo verso Dio: presunzione e superbia, sospetto e incredulità, risentimento e rancore, ansia e depressione, scetticismo e diffidenza, odio e bestemmia, ribellione ed immoralità. A questo punto viene spontanea una domanda:
“La prova è positiva? E’ giusto che un padre metta alla prova un figlio?”
La risposta è affermativa, al di là della modalità della prova, ogni prova in sè stessa è giu- sta, opportuna e necessaria. La prova è usata in tutti i campi: lavorativo, scolastico, so- ciale; la prova segna ogni ingresso e ogni progresso della vita.
6
Quindi, un buon padre conduce i figli anche ad affrontare le prove della vita con saggezza pedagogica, per fortificarli e addestrarli, per verificarli e valutarli, per correggerli e perfe- zionarli, per formarli ed educarli; per poi premiarli quando risulta che hanno dato buona prova d’amore e fedeltà, di sapienza e saggezza, di forza e sacrificio, di equilibrio e buon senso, di coraggio ed impegno, di bravura e successo.
In Sir 2,1 troviamo scritto “Figlio se vuoi servire il Signore preparati alla prova”.
Tanto è positivo questo Indurre o Condurre nella prova, che Gesù stesso, questa volta dal- lo Spirito Santo, “E’ stato portato nel deserto per essere tentato dal diavolo” (Mt 4,1).
Al “deserto”, già situazione-occasione di prova di Dio, si è aggiunta poi la triplice prova del tentatore Satana.
Se si fosse adottata la proposta del biblista Piero Bovati: «Non ci mettere alla prova» si sarebbe modernizzata l’espressione nel pieno rispetto del senso delle parole di Gesù.
La parola prova, nel nostro lessico, ha un senso molto ampio e positivo.
Il Padre Celeste e lo Spirito Santo, che ha un cuore materno (Ruah in ebraico è un termine di genere femminile), possono avere l’intenzione buona e giusta di provare l’ubbidienza e la fedeltà dei figli. Si tratta di una Prova divina, sempre da benedire sia quando dà, sia quando toglie (Giobbe 1,20-22).
Anche nell’ordinamento giuridico c’è la “messa alla prova” con lavori socialmente utili, con buoni frutti: ottiene il vantaggio di evitare processo e condanna penale.
Spiritualmente parlando, al momento del giudizio particolare dopo la nostra morte, grazie alle prove della vita, accettate e offerte, avremo uno “sconto” di pena da Dio, che può ini- ziare già durante la vita terrena come un’”indulgenza” presente e futura.
Così come la Prova divina, anche la Tentazione del Demonio dev’essere considerata posi- tiva, perché ci spinge, ci obbliga ad essere più forti del nemico, più bravi di lui, e il supera- mento della tentazione ci porta ad essere vittoriosi e virtuosi.
INDURRE IN TENTAZIONE
Approfondiamo ora meglio il verbo «Indurre» in relazione alla tentazione/prova.
Vi risparmio le analisi dei vocaboli in Aramaico, Greco e Latino, riportandovi solo le con- clusioni sicure di questi studi esegetici e filologici.
E’ interessante notare il fatto che anche in Italiano, come nelle lingue bibliche, il verbo In- durre ha una duplice serie di sinonimi: potremmo definirle una serie negativa una serie po- sitiva. Queste serie sono seguite dalla parola Tentazione, che prende anch’essa un senso “negativo” di seduzione, lusinga, allettamento, adescamento; e un senso “positivo” di in- tento, testazione, saggio, sperimentazione, con la variante di traduzione e di significato che è il sostantivo Prova.
Il primo senso del verbo Indurre è sinonimo di istigare, incitare, sollecitare.
Si presta bene ad essere riferito ad una tentazione, ad un peccato, ad un errore, ad un male che viene favorito da qualche occasione, situazione, condizione, e che viene causato da una nostra incoscienza, imprudenza e impulsività; oppure che viene determinato da qual- che orchestrazione e combinazione del maligno, o di persone maligne.
Il secondo senso del verbo Indurre è sinonimo di condurre, avviare, iniziare.
Si presta bene ad essere riferito ad una prova, ad un esame, ad una verifica, ad un saggio, ad un bene inteso come un giusto pensiero (sono indotto a pensare che…) o come un buon comportamento (mi stai inducendo a fare …) nei quali essere confermati e promossi per rettitudine e onestà, oppure per purificazione e correzione.
7
Tradurre con la parola Prova è perfettamente pedagogico, istruttivo, saggiativo, forma- tivo e si adatta giustamente al Padre “che si prega” e al figlio “che chiede”.
Un padre legittimamente, sapientemente e doverosamente “mette alla prova il figlio”, per testarlo e fortificarlo, anche se il figlio ha diritto di chiedere che la prova non sia troppo dura e ardua, superiore alle proprie forze, priva dell’aiuto del Padre.
Allora possiamo concludere che entrambi i sensi calzano bene con l’intenzione della pre- ghiera di Gesù, purché si traduca in un modo duplice la parola «Tentazione», come è del resto nella lingua biblica, che può essere tradotta anche come «Prova».
Anzi, questa è la traduzione più giusta in quanto fa riferimento a Dio, al Padre che si sta pregando: Gesù parlerebbe delle “Prove di Dio”, sia come “Prova del giusto” sia come “Punizione del peccatore”.
Questi concetti sono molto presenti nella Bibbia e sono legati a tutti i grandi personaggi biblici, come: Abramo (Gen 22,1), Giacobbe (Gen 32,25-33), Giobbe e allo stesso popolo di Israele (Dt 13,4 e Gdc 3,4).
Si tratta di concetti positivi, anche se dentro esperienze difficoltose e dolorose.
Allora, aver sostituito «Indurre» con «Abbandonare» vuol dire aver ridotto il senso del ter- mine da duplice (Prova e Tentazione) a unico (Tentazione), aver introdotto un elemento negativo in una serie di frasi e domande solamente positive.
Che la parola «Tentazione» sia da intendere e tradurre con la parola «Prova» risulta anche dall’uso ebraico delle endiadi, che è indicato da il «ma» di «ma liberaci dal maligno».
Si usa, infatti, mettere due frasi in parallelo e in contrapposizione; per cui se nella prima frase si parla di una “Prova di Dio”, «Non ci indurre alla prova», nella seconda frase si parla del Nemico di Dio, il Maligno, che prova a far cadere il giusto “sette volte” (Prov 24,16), un giusto che poi si rialza con l’aiuto di Dio, liberatore dal Maligno.
Anche nella letteratura e nella pratica linguistica il verbo «Indurre», con significato di con- durre, è seguito in maggioranza da avverbi positivi, quali: saggiamente, opportunamente.
Il verbo «Indurre» è spesso associato a belle immagini, come quelle di un papà o una mamma che accompagnano un figlio per mano; iniziano un figlio al lavoro; istruiscono un figlio per una sua realizzazione, soddisfazione, successo; provano un figlio per portarlo a fare il bene ed evitare il male; per condurlo a progredire nelle virtù e a evitare i vizi; ad ope- rare giustizia, carità ed a non aderire a ingiustizie, trasgressioni, immoralità e delinquenze. Un figlio buono è cosciente della positività giusta e pedagogica della “Prova del padre”, ma è anche normale che egli chieda al padre che la prova sia scontata, annullata, o almeno alleggerita ed abbreviata; in virtù dell’amore che il padre ha per lui (in quanto figlio ubbi- diente alla sua volontà) e in virtù del fatto che il figlio crede nell’autentica e totale bontà del padre, così come credeva Gesù, al punto tale che una volta ha rifiutato per lui stesso la qualifica di “buono” per riservarla unicamente a Dio (Mc 10,17-18) (Mt 19,16-17).
Quando un figlio chiede al padre di essere esonerato da una prova, esprime anche tutta la buona volontà di dare il massimo di sé, sia nell’ubbidire alla volontà del Padre, sia nel cor- reggersi dalle disobbedienze a Dio, in modo tale da rendere superflua ed evitabile la “prova” stessa, e ancora di più la “correzione” (Prov 13,24) (Ebr 12,6).
Tra un Padre così buono e un figlio così ubbidiente non può affatto inserirsi la parola «Abbandono» nella Preghiera.
Queste considerazioni, unite al fatto che in Greco (la lingua del Vangelo) gli stessi vocabo- li hanno più significati e più traduzioni in base al contesto in cui sono inseriti, ci fanno concludere che la traduzione giusta sia la parola «Prova». Essa racchiude in sé molteplici situazioni: la malattia psichica e fisica, la miseria, la disgrazia, la guerra, la persecuzione, la morte, il peccato, il vizio, l’errore, l’immoralità, l’infestazione, la possessione, il turba- mento, la tentazione del maligno… La prova ci ottiene sia la grazia, sia la salvezza.
8
Ecco altri passi in cui il vocabolo «Tentazione» (peirasmon) assume il significato e la tra- duzione di «Prova»: Lc 22,28 ; Lc 4,12-13 ; Lc 20,40 ; Mt 26,41 ; 1 Cor 10,12-13 ; 2 Pt 2,9 ; Ebr 3,8; Att 5,9 ; Deu 6,16 ; Mt 19,3 ; Mt 22,18 ; Gal 6,1.
Tutti questi testi parlano di «Prova» e la parola «Tentazione» indica una prova i cui attori sono Dio, con la sua volontà da considerarsi sempre buona e giusta, pedagogica e provvi- denziale con finalità di santificazione e conversione, oppure il diavolo, con la sua attività libera e malvagia di tentatore, praticata sempre nei limiti e nei tempi stabiliti e permessi da Dio. Proviamo ad immaginare che questa sesta espressione non ci sia nel “Padre Nostro”, o fosse travisata, potremmo arrivare a soffrire di tutto, a cominciare da: debolezze, trasgres- sioni, incoscienze, ansie, stoltezze, incoerenze, ingenuità, inganni, disobbedienze, falli- menti e crisi nelle prove della vita, schiavitù del peccato e del tentatore, fino alla perdizio- ne eterna.
INDURRE O ABBANDONARE?
Alla luce di quanto esposto, aver cambiato «Indurre» in «Abbandonare» e aver lasciato la parola ambigua «Tentazione» mi sembra la peggior traduzione che si poteva fare.
Quel che è peggio è che questa traduzione può far pensare a un peccato di omissione da parte di Dio Padre se ci dovesse abbandonare, e questo è inverosimile, così come è assurdo che un figlio preghi il padre di non essere da lui abbandonato.
Dio non potrà mai abbandonare, cioè “dimenticare” un figlio: i Salmi e i Profeti continua- mente e fortemente insistono su questa verità (Sl 137,5-6) (Sl 27,10) (Is 49,15).
Allora non ha senso pregare per non essere abbandonati.
Perfino nel linguaggio corrente il verbo «Abbandonare» assume spesso una valenza nega- tiva: per esempio, richiama l’abbandono di un minore, l’abbandono degli studi e del lavo- ro, il rifiuto di una responsabilità, il distacco affettivo in famiglia.
Ma ciò che è più grave nell’espressione «Non abbandonarci alla Tentazione» è che si tratta “sotto-sotto” di una specie di bestemmia indiretta e di un’espressione di grave incredulità. Questa formulazione cela in sé una sorta di offesa verso colui al quale ci si rivolge e contiene una mancanza di fede nei suoi riguardi.
Infatti, supponiamo che un figlio, in un momento di grave malattia o di grave crisi e fatica, dica al papà (o alla mamma): «Non mi abbandonare». Questo genitore potrebbe sentirsi offeso, quasi insultato, perché il figlio insinuerebbe o sospetterebbe che il padre non è un buon genitore e non ha amore e cura per lui; e inoltre perché il figlio darebbe da intendere che non ha fiducia e non è sicuro della grande ed eterna paternità e maternità del genitore. Oltre a questa “specie di malignità e bestemmia” c’è da considerare un altro aspetto: il fi- glio che dice al genitore «Non mi abbandonare», è un figlio che non ha fede, è pauroso, è angosciato dal dubbio, dal timore, dall’incredulità e dalla sfiducia; tutti sentimenti che Ge- sù ha sempre detto di non avere, e che ha sempre stigmatizzato (Mt 8,26).
Purtroppo anche nella liturgia, a volte, si usano espressioni negative come queste: “Signore, non lasciarci soli”, “Signore, non privarci della tua Misericordia”, senza accor- gersi che alla base di tali espressioni ci possono essere un sospetto, un’offesa, un’accusa a Dio e una nostra paura, una poca fede e un’incredulità.
Tutto ciò non si addice a Dio, non appartiene al Padre un sentimento e un atteggiamento di abbandono di un figlio, e quindi egli non dovrebbe mai usare il verbo «Abbandonare» nel- la sua Preghiera.
Gesù non avrebbe mai detto, né fatto dire a noi una Preghiera di questo genere.
9
E’ inconcepibile questa visione negativa di Dio “che è pregato” e questo sentimento nega- tivo dell’uomo “che prega”, espressi sia pure in modo indiretto, come allusione subdola, insinuazione velata e sottile, che ferirebbero il cuore di Dio Padre e non si addirebbero al cuore di un vero figlio.
C’è poi da considerare l’impatto psicologico che a lungo andare può avere nei fedeli la presenza del termine «Abbandonare».
Già questa parola ricorre sulla bocca di tante persone come bestemmia indiretta: “Dio mi ha abbandonato!”. In questo contesto pare di intravedere il sorgere della mentalità del «fratello maggiore» (Lc 15,29-30) che rivendica la sua fedeltà e la sua ubbidienza a un Dio che sarebbe irriconoscente e ingiusto; un figlio che ragiona con sentimenti di presunzione e di risentimento verso il Padre.
Al contrario, il parlare di Conduzione da parte di Dio, in una prova saggiatrice e fortifica- trice, o correttiva e castigativa (da castum agere = rendere casto e puro) provoca sentimenti da «fratello minore», il quale con umiltà e pentimento accetta sia l’esame del Padre per il buon comportamento, sia il giudizio di Dio per il cattivo comportamento.
Il figlio si lascia così condurre in un cammino di santificazione e di conversione, al termi- ne del quale ci sarà la promozione del Padre, la riconciliazione con Dio, la gioia del cielo, il perdono, la riabilitazione di Dio e il premio del Paradiso.
E al tempo stesso la sua vita terrena sarà abbellita dal fiorire di tante grandi virtù, verso Dio e il prossimo, come: fede, amore, sacrificio, speranza, compassione, comprensione, generosità, carità, umiltà, fiducia, bontà, fortezza, giustizia, ecc.
Queste virtù, tipiche dei Santi sono anche definite “provate virtù”, in quanto Dio le ha mes- se alla prova, testandole con pericoli, fatiche, sacrifici e i Santi hanno accettato queste pro- ve, spesso dolorose, con umiltà, pazienza, penitenza, rendendo queste virtù delle abitudini stabili, buone, perfette.
Quindi, fa parte della pedagogia divina di Dio Padre provare le nostre virtù per renderci santi, anche se ciò non toglie che noi, con umiltà e verità, non essendo sempre santi, chie- diamo che le prove non siano troppo pesanti per la nostra debolezza umana nella Santità, per la nostra incoerenza e infedeltà.
Allora possiamo concludere dicendo che la sostituzione del vocabolo «Indurre» in «Abbandonare» oltre ad essere un errore filologico è anche un vero e pericoloso travi- samento di senso, in quanto si riferisce solo al diavolo e alla sua tentazione, ed esclude tutta la grande e importante rivelazione di un Dio che mette alla prova il giusto per perfezionarlo e santificarlo, e il peccatore per correggerlo e salvarlo.
DIO MIO, PERCHE’ MI HAI ABBANDONATO?
A sostegno del verbo «Abbandonare» non può essere citata neppure la frase pronunciata da Gesù sulla croce: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt 27,46).
In primo luogo non si tratta di una preghiera, in secondo luogo è una citazione del Salmo 22,2, in terzo luogo si tratta di una domanda, un drammatico interrogativo e non di una di- chiarazione.
La frase, il grido di Gesù non è esclamativo: “Dio, mi hai abbandonato!”, ma è interrogati- vo: “Perché mi hai abbandonato?”.
Gesù chiede il perché dell’abbandono alla morte solo dopo esser giunto all’apice del dolo- re, della sofferenza, della persecuzione, della Passione, della Croce, e avendo anche rag- giunto il culmine della sua obbedienza alla volontà del Padre, del suo sacrificio redentore pienamente compiuto, del suo dono totale della vita per amore.
10
Gesù al pari di ogni uomo, coinvolto in gravi situazioni di passione e di croce, di persecu- zione e di martirio, di olocausti e di genocidi, di guerre e di tragedie, di malattie e di dolo- ri, ha il diritto di chiedere a Dio una spiegazione per questi “abbandoni”.
La richiesta di una spiegazione del motivo e della finalità dell’abbandono di Dio, è una domanda legittima, giusta, dignitosa; è un diritto sacrosanto e morale chiedere una risposta, ed è un dovere assoluto da parte di Dio dare una spiegazione della causa e del fine di queste “prove-tentazioni” segnate dall’abbandono di Dio.
Gesù ha detto agli Apostoli di conoscere già la risposta al suo interrogativo: è quella che culmina nella Risurrezione (Mc 8,31).
Ma sappiano da altre espressioni di Gesù che l’abbandono alla Passione e alla morte serve a manifestare l’amore più grande per gli amici (Gv 15,13), ad ottenere dal Padre il riscatto e la liberazione degli uomini dal Demonio (Mt 20,28), la Redenzione e la giustificazione dell’umanità (Lc 21,28 e Lettere di Paolo), la remissione dei peccati, il perdono, la salvezza, la nuova ed eterna Alleanza, la giustizia, come pure la grazia, la potenza, la vittoria, il trionfo, la gloria.
Ciò non toglie, tuttavia, che Gesù nel momento più estremo e drammatico della sua umani- tà martirizzata abbia voluto chiedere il perché, fiducioso e sicuro di ottenere una risposta Divina.
Chiarito questo, nella ricerca dell’imitazione di Cristo possiamo concludere chiedendoci se Gesù abbia pregato affinché non fosse Lui stesso condotto nella prova, nella tentazione.
La risposta è affermativa: Sì! Gesù ha pregato per questo sicuramente in occasione dei “Quaranta giorni e quaranta notti” nel deserto, prima delle tre Tentazioni che poi ha vinto (Mt 4,2).
Ma la risposta più chiara ci giunge analizzando la parte iniziale della sua “Ora” più dram- matica e dolorosa, quella dell’agonia con sudore di sangue, vissuta da Gesù nell’orto del Getsemani, quando prega: “Abba, Padre! Tutte le cose sono possibili a te, porta via questo calice da me”. Come a dire: “Non mi indurre a bere questo calice della Passione e della morte in croce”, ma “Non cosa io voglio, ma cosa tu vuoi”.
Ciò che Gesù voleva, possiamo sicuramente pensare che era espresso in una preghiera di questo tipo: “di non essere indotto a bere il calice”, preghiera fatta da Lui per un’ora, con tristezza, angoscia, spavento, con insistenza e intensità, come scrivono gli Evangelisti (Mc 14,36).
Anche Luca (22,42) scrive “Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta”.
Così Matteo (26,39): “Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come tu vuoi”.
Si tratta certamente del calice dell’amarezza e del dolore, caratterizzato da un duplice si- gnificato simbolico: se da un lato esso rappresenta il “calice della persecuzione” da parte degli uomini cattivi e crudeli, peccatori e malvagi verso di Lui, come Agnello espiatorio (1Cor 11,26) (Is 50 e 53), dall’altro simboleggia anche il “calice dell’ira” da parte di Dio verso Gesù “il servo di Jahvè”, caricato dei peccati di tutti gli uomini (Is 51,17) (Ap 16,19).
Nella stessa ora, ma dopo la sua, Gesù insisteva presso gli Apostoli perché vegliassero e pregassero con Lui per non entrare o essere condotti anche loro in tentazione, riconoscen- do che “Lo spirito è pronto, ma la carne è debole” (Marco 14,38), sia nel resistere alla pro- va, sia nel non cedere alla tentazione; sia pure con la consolante certezza (scrive Paolo in 1 Cor 10,13) che le prove per noi sono umanamente sopportabili, perché Dio è fedele e non permette che siamo tentati oltre le nostre forze, e poi ci offre sempre una “via d’uscita”, con Grazie e miracoli, dopo essere stati condotti nella via dolorosa della prova e della ten- tazione.
11
Davanti a questa cruciale, sofferta, eroica preghiera di Gesù agonizzante espressa da Lui più di noi e prima di noi, riusciamo a capire questa cosa: è proprio dal fatto che Gesù ha rinun- ciato alla sua preghiera, cioè quella di non essere indotto a bere il calice del martirio sulla Croce, che noi abbiamo avuto la salvezza e la grazia, la redenzione e la giustificazione.
La rinuncia di Gesù fu dettata dall’amore per il Padre e per l’umanità, come si deduce dall’interrogativo in Gv 18,11: “(Pietro) Metti la spada nel fodero. Forse che io non dovrei bere il calice che il Padre mi ha dato?”.
Gesù aveva la piena e sicura consapevolezza che la sua preghiera avrebbe potuto essere esaudita (Mt 26,53) con “Dodici Legioni di Angeli”, cioè con un’armata Angelica, in suo aiuto, protezione, liberazione, come già avvenuto, in concorso con i carismi divini del Si- gnore, nelle tentazioni del deserto (Mt 4,11), nel tumulto di Nazareth (Lc 4,28 30) e nell’at- tentato al tempio (Gv 8,58-59).
L’umanità è stata redenta dal sacrificio di Gesù sulla croce, il Padre è stato glorificato con la Risurrezione di Gesù dai morti, grazie a questa accettazione della volontà del Padre per il suo martirio e grazie alla rinuncia dell’esaudimento della sua volontà che Gesù avrebbe potuto chiedere pregando di «non essere condotto» a bere «il calice» dei votati alla prova, dei condannati a morte, dei peccatori a cui spetta fuoco e vento bruciante come «la parte del loro calice» (Sl 11,6).
E’ una rinuncia che potrebbe toccare anche noi, suoi discepoli, come preannunciata a Gia- como e Giovanni: “Il mio calice, sì, lo berrete” (Mt 20,22-23).
Tutte le nostre preghiere per non essere condotti in prova o in tentazione si dovrebbero concludere così: « … Ma non come voglio io, ma come vuoi tu, o Padre!».
Per questa nostra rinuncia di preghiera, Dio ci darà ricompensa e premio.
CONCLUSIONE
Questo mio studio non va preso come una critica, ma come un contributo alla ricerca della verità, per essere veramente «Ubbidienti alla parola del Signore e formati al suo Divino insegnamento», e al tempo stesso vuole essere sempre aperto ad ulteriori approfondimenti ed eventuali correzioni.
Non ho intenzioni politiche e non voglio essere coinvolto nello scontro tra tradizionalisti e progressisti, nelle diatribe preconciliari e post-conciliari, nelle fazioni a favore del “Nuovo Padre Nostro” o del “Vecchio Padre Nostro”, ma sto semplicemente cercando la verità.
Sebbene ci dobbiamo adeguare liturgicamente alla “nuova” redazione: «Non abbandonarci alla tentazione», nella recita privata e personale ciascuno potrà, in “obiezione di coscien- za” continuare a pregare: «Non ci indurre in tentazione», in ossequio alla regola apostolica per cui “Bisogna ubbidire a Gesù Cristo piuttosto che agli uomini” (At 5,29).